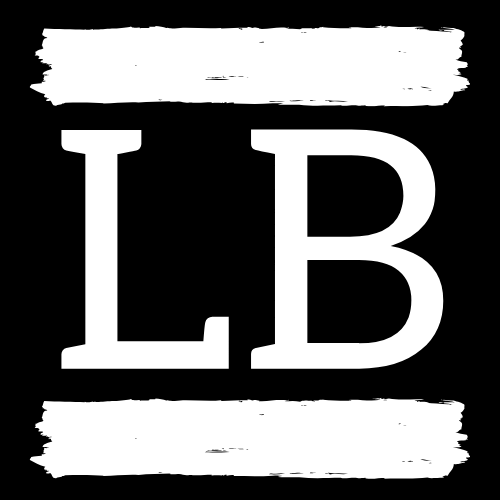Ieri, dopo qualche giorno dedicato ai movimenti diplomatici e militari attorno al Piemonte e in Piemonte, abbiamo iniziato a scoprire com’è strutturata la società torinese di inizio 1700. Abbiamo parlato del Duca e della corte, dell’aristocrazia e dell’alta borghesia.
Scendendo dalla piramide gerarchica, ecco il ceto medio. Non può ambire a grandi orizzonti, perché il Ducato di Savoia non gode di traffici particolarmente vasti e non ha mercati internazionali di riferimento, come le colonie d’oltreoceano. In compenso, il monopolio interno è ben regolato e garantisce al piccolo borghese sabaudo sicuri profitti che non temo concorrenza né rischi. Eccolo, l’uomo del ceto e medio: ordinato e tranquillo, religioso, devoto al Duca. Si accontenta di avere una famiglia laboriosa e sottomessa e se ogni tanto prova a sognare in grande, sogna un impiego da segretario per qualcuno degli apparati cittadini o del Ducato. Si vendica dell’arroganza e del disprezzo dei nobili raccogliendone e commentandone gli scandali e le disgrazie di corte, i debiti e le cadute.
I mercanti e gli artigiani di Torino erano raggruppati e ordinati in 30 corporazioni, ciascuna con statuti, capi, cappelle, feste religiose e santi patroni. Se andiamo a visitare la cappella della Pia Congregazione dei Banchieri e dei Mercanti possiamo farci un’idea dello splendore (e della ricchezza) di questi ordini professionali settecenteschi. Queste congregazioni erano chiamate anche “Università”, ed erano simili ma distinte dai collegi (degli avvocati, dei procuratori, dei cerusici e dei farmacisti).
Scendendo sempre più in basso nella gerarchia sociale, ecco commessi di negozio, servi (un’enormità, vista la presenza della corte e di tante casate nobiliari e altoborghesi), cocchieri, facchini… fino agli operai propriamente detti, in verità non moltissimi: nel 1706 a Torino c’era una sola fabbrica di stoffe che dava lavoro a 70 dipendenti. La classe agricola, infine, era emigrata fuori città, nelle cascine e nelle vigne dei dintorni.
Tutto qui? naturalmente no. Rimanevano i vagabondi, gli accattoni, i fannulloni che vivevano delle elemosine e delle donazioni fatte alle porte dei conventi e dei palazzi, ed erano accolti da istituzioni come l’Ospedale di Carità, oppure vivevano accampati nei tuguri dei sobborghi cittadini.
Esclusa la nobiltà, le altre classi sociali non si distinguevano certo per ardore militaresco. In due secoli e mezzo i Duchi avevano cercato di ordinare una milizia cittadina, ma alla fine del 600 questa era un’accozzaglia messa su a furia nei momenti del pericolo e abbandonata subito dopo. A ogni chiamata bisognava rifare il censimento degli arruolabili, riformare gli ufficiali e bandire severe minacce. Nel 1706, con la minaccia dei francesi alle porte di casa e il concreto timore di finire nelle loro mani, la popolazione tirò fuori il meglio di sé: ispirati dal coraggio dei soldati e dall’esempio del Duca, fabbri, falegnami, muratori e altri artigiani prestarono la loro opera al servizio della causa, e perfino donne e bambini non si tirarono indietro dal pericolo.
La polizia era severa e temuta. Perfino eccessiva nei sospetti e feroce nella repressione, si affidava alle denunce dei delatori e a una fitta rete di informatori. La cittadina era affidata al Vicario e ai suoi cavalieri, con l’aiuto dei cantonieri, uno per cantone o isolato, che denunciava i reati, teneva registro dei cittadini e nota di forestieri, vagabondi e schiamazzatori, manteneva scritti i nomi delle strade agli angoli delle case, sorvegliasse i pozzi e gli attrezzi per spegnere gli incendi.
Merita infine fare un cenno sulla vita culturale della Torino dell’epoca. Che, come accennato ieri, non era particolarmente florida. Si racconta di lauree comprate, di incuria e cupidigia dei dottori, di cattedre assegnate con criteri tutt’altro che meritocratici. L’insegnamento di teologia e filosofia, di cui l’Università di Torino andava fiera, era stato impoverito da quando i padri Gesuiti avevano ottenuto la facoltà di impartirlo nel proprio collegio. All’epoca dell’assedio rimanevano sei “lettori” di Legge, cinque di Medicina e Chirurgia, due di Teologia e Filosofia. E nessuno di Lettere.
I Gesuiti erano gli unici a non annegare in quel naufragio culturale. Dopo aver iniziato a insegnare lettere e scienze nel loro collegio, grazie alle donazioni della Madama Reale avevano innalzato il Collegio dei Nobili (l’attuale Accademia delle Scienze) dove venivano insegnate retorica, grammatica, filosofia, matematica… ma anche scherma, danza ed equitazione.
Per fortuna, si può dire, la classe dominante sopperiva con il senso pratico e il buon senso dell’amministrazione al difetto di cultura, specie letteraria. Prima e durante l’assedio, ragionieri e impiegati dei vari ministeri furono bravissimi ad alimentare la città e il presidio militare e al tempo stesso controllare le spese, facendo censimenti, aprendo mutui e chiedendo prestiti, vendendo terre, tassando i tributi e distribuendoli dove necessario.
Il 12 dicembre 1706, Vittorio Amedeo comunicò ai sindaci “di far sapere che era soddisfattissimo di tutte le operazioni della città, dei signori suoi consiglieri e della cittadinanza e del loro buono affetto e zelo dimostrato in tale occasione”, ossia durante il vittorioso assedio.
A dimostrazione, una volta di più, che il merito della vitoria (e che vittoria!) fu di tutti i torinesi, e non solo di quelli che impugnarono le armi.
Il dipinto a inizio post è di Giovanni Michele Graneri.