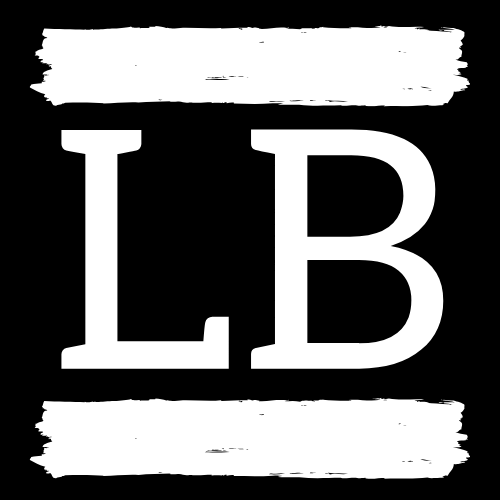Palazzo Provana di Druent
Pietro Aglieri si fermò davanti alla finestra per sbirciare attraverso gli assi che la sbarravano. Bagliori sinistri riempivano il cielo notturno.
«L’Inferno si prenda i Francesi e la guerra!»
Non passava più giorno senza che su Torino si abbattesse una pioggia funesta, e le gocce erano grosse e nere, con un filamento incandescente che si lasciava dietro una scia di fumo. Quando quella pioggia toccava terra c’erano tetti sfasciati, palazzi che crollavano e persone che morivano.Dalla Cittadella, dove la battaglia infuriava, proveniva il borbottio di un enorme stomaco in subbuglio, e il vento portava l’odore acre della polvere da sparo. Pietro riusciva a riconoscere il suono dei tamburi dei reggimenti, ordinati e continui, e le scariche dei moschetti che sembravano scrosci di grandine.La testa gli faceva male come dopo una sbornia, anche se non aveva toccato vino.
Soltanto un goccio, a dire il vero.Un bicchiere di quello buono, forse due. La cantina del palazzo a sua disposizione, e nessuno che potesse fare la spia. Sarebbe stato un delitto non approfittarne.
Uno o due bicchieri, non di più. Monsù Druent l’avrebbe fatto frustare se l’avesse sorpreso ubriaco, oltretutto quando gli era stato ordinato di fare la guardia.In strada passò una squadra di soccorso che forse andava a spegnere un incendio. Ormai capitava di continuo: una bomba scoppiava e una casa bruciava. Accorrevano mastri da muro, falegnami e brentatori con i loro preziosi strumenti del mestiere che, anziché vino, trasportavano litri e litri d’acqua.
La Cittadella era un bersaglio difficile da colpire: merito dei lavori di monsù Bertola, stimatissimo ingegnere del Duca, che aveva fatto spianare boschi, scavare fossati e innalzare colline. Torino, invece, era un bersaglio molto più grande e facile da colpire. E quando il generale la Fojada(che Dio maledica anche lui!)
aveva rivolto i cannoni sulla città, le bombe non avevano avuto riguardo per nessuno. Nemmeno per la Duchessa, i principini e la Madama Reale, visto che un boulet rouge, una bomba incendiaria, era piombata sulle scuderie del Palazzo Ducale proprio mentre si apprestavano a partire per Cherasco. Erano rimasti illesi per miracolo. O per puro caso.
Pietro si portò la fiasca alla bocca e piegò la testa indietro: l’acqua gli scivolò in gola, schizzò sulle labbra e sul mento, gocciolò sul petto. Le fitte continuavano a tormentargli le cervella.
«Alla salute di quella canaglia che mi tiene qui a morire.»
Non osava pronunciare ad alta voce il nome del padrone, Giacinto Antonio Ottavio, conte Provana e signore di Druento: in quel palazzo
anche i muri avevano orecchie, forse anche adesso che non c’era nessuno.La Congregazione aveva comandato di portare via fieno, carbone, legna e materiali infiammabili dalla Città Vecchia, e di accogliere nelle
cantine l’acciottolato rimosso dalle strade, per impedire che le palle nemiche vi rimbalzassero.
La maggior parte degli abitanti della zona era stata sfollata: chi poteva permetterselo si trasferiva da amici e parenti, gli altri si accampavano nei prati di Vanchiglia o sotto i portici di via di Po.Anche monsù Druent se n’era andato con tutta la famiglia e la servitù, ma Pietro era rimasto, a turno con altri valletti e stallieri di casa, a sorvegliare la casa del padrone dai ladri e dai saccheggiatori.
E se una bomba sfonda il tetto, non ammazzerà che un servo.
Pace all’anima sua. E che Dio maledica monsù Druent.Il caldo era asfissiante e non c’era da stupirsi che la testa gli facesse male. Si passò la mano sulla fronte e le dita s’inumidirono di sudore
appiccicoso. Reggendosi alla balaustra, iniziò a salire la scalinata per fare il giro delle stanze e controllare che nessuno si fosse arrampicato su un balcone o avesse forzato una delle finestre. Quegli equilibristi zingari che aveva visto in piazza Carlina ne sarebbero stati capaci.
I passi echeggiavano nella volta nera dell’atrio, il movimento dondolante della lampada faceva danzare le ombre al ritmo del pulsare doloroso della testa, e tutto sembrava in sincronia con il rimbombo dei cannoni.Pietro arrivò in cima alla scalinata con la testa che sembrava sul punto di scoppiare, fradicio di sudore.
A qualche passo da lui c’era il quadro di Matilde, la sventurata figlia di monsù Druent, ritratta con l’abito della festa e lo sguardo verso la
scala. Pietro fece in tempo a pensare che fosse una scelta di cattivo gusto mettere un quadro
(quel quadro)
proprio lì: quello stesso scalone era crollato il giorno della festa di matrimonio di Matilde, e nella confusione per poco non era andata persa la collana che la sposa aveva avuto in prestito dalla Duchessa di Savoia.
Adesso tutti sapevano che era stato un cattivo presagio, ma il Conte suo padre aveva vietato di parlarne. Dello scalone, del cattivo presagio, del matrimonio. Della figlia.Pietro chiuse gli occhi, li riaprì di scatto.
Al pulsare della testa si era unito quello del cuore, così violento che pareva volesse scappare dal petto. La pelle si accapponò per un brivido di freddo.Non c’era mai stato un quadro in cima allo scalone. Non c’erano più quadri di Matilde in casa, perché monsù Druent non amava le sconfitte e qualunque cosa gliele ricordasse. Matilde si era uccisa buttandosi dalla finestra quando suo padre le aveva ordinato di tornare a casa pur di non pagare la dote matrimoniale pattuita.
Pietro soffiò un respiro tremante e lo vide formare una nuvola davanti ai suoi occhi. I brividi non arrivavano da dentro di lui, comprese, ma da tutto intorno. Il calore dell’estate era svanito come se qualcosa l’avesse risucchiato via.
Matilde Provana era morta suicida da cinque anni, eppure era lì, di fronte a lui, gli occhi sbarrati e senza espressione. Qualcosa vorticò sulle labbra dello spettro piegandole in una specie di sorriso.
«T r a d i t o r e » disse. La voce sembrava la stessa che Pietro ricordava, eppure diversa, in un modo che avrebbe saputo spiegare solo
paragonandola a un sussurro portato dal vento.
«T r a d i t o r e. »
La sagoma vacillò, come se fosse stata al di là di una parete d’acqua, e un istante dopo fu inghiottita dalle tenebre.Pietro si fece avanti con cautela per toccare il muro. Era solido, tiepido per il calore trasudato dopo un’altra giornata torrida. Niente buchi,
niente fessure. Niente porte nascoste dalla tappezzeria. Batté la parete con le nocche della mano. Il suo mal di testa era più forte che mai e anche il caldo era tornato, o forse non era mai andato via.Traditore…
Era a lui che si rivolgeva, madama Matilde? A lui che aveva tradito la fiducia del padrone bevendo il vino della sua riserva?
Pietro serrò le labbra e strinse i denti. Sarebbe morto piuttosto che raccontare a qualcuno ciò che aveva appena visto. Altrimenti monsù
Druent sarebbe venuto a saperlo. E si sarebbe arrabbiato, oh, se si sarebbe arrabbiato.Gli unici spiriti di cui riconosceva l’esistenza, il padrone, erano quelli del vino. E Pietro non aveva alcuna intenzione di farsi licenziare con
l’accusa di essersi sbronzato durante il turno di guardia. O, ancor peggio, per aver creduto di vedere qualcuno che doveva essere morto e sepolto.***
Borgo Dora
Se qualcuno fosse entrato nella bottega in quel momento, avrebbe potuto confondere Fioreste Chevalier con una scultura di legno dipinto, dimenticata tra gli scaffali e i vasi di fiori secchi. Una statua dai lineamenti pensosi, forse di un santo che attendeva di essere portato agli onori di incensi e preghiere.
«Gi-a-soli.» Fioreste appoggiò la mano buona su quella avvizzita e incominciò a strofinarla lentamente.
Laura lo incoraggiò con un sorriso, senza smettere di lavorare.
«Certo, i girasoli. Siamo a giugno, in piena fioritura.»
«E-ano belli, i miei gi-a-soli, eh?» Fioreste ricordava i suoi campi di fiori a Nizza, quand’era un ricco e importante mastro profumiere.
«I più bei campi di girasole di tutta la riviera» lo accontentò Laura. Sarebbe piaciuto anche a lei tornarci: a quei campi sull’altopiano, alla cascina, alla sua stanza con la finestra affacciata sul mare, al laboratorio di profumi.Da fuori giungevano le voci della strada, le mosche che ronzavano e il monotono chiocciare delle galline. Sullo sfondo, il martello di monsù Clemente si abbatteva sull’incudine. Erano i suoni di tutti i giorni che accompagnavano la giornata in quel lembo di terra tra le mura di Torino e la Dora: una ragnatela di vie, baracche, mulini e botteghe che qualcuno chiamava “Balòn” e altri “Borgo Dora”.
«G-uatta più fine» invitò Fioreste indicando il secchio dove si accumulavano le scaglie di sapone. Gratta più fine.
Ormai Laura si era abituata a sentirlo parlare così, come un ubriaco.
Vederlo ridotto in quello stato le stringeva il cuore, e ogni volta le veniva da ricordare l’uomo che era, prima che la paralisi gli portasse via
metà del corpo.(Prima che fossimo costretti a scappare a Torino
Prima che la mamma morisse.
Prima che Maurizio ci portasse via tutto per goderselo in fondo a un pozzo)Il loro garzone non li aveva solo derubati del denaro e delle essences absolues. Il suo inganno criminale aveva arrecato tanta rabbia e dolore a Fioreste che il suo cuore era andato vicino a fermarsi per sempre.
Gli sbirri del Duca non erano riusciti a punirlo perché un’altra giustizia si era abbattuta su di lui: Maurizio era morto forse la stessa notte del suo furto, sbranato dai lupi o dalla bestia che la gente chiamava l’Uomo del Crocicchio e che si diceva fosse un diavolo. O il Diavolo in persona. Un brivido attraversò Laura dalla schiena alla punta dei piedi, eppure nella bottega faceva caldo, perfino con la porta e le finestre aperte.
«Cerèa, monsù Fiorest!» esclamò qualcuno da fuori, nel dialetto di Torino.
«Bon-sjou-u!» biascicò il profumiere, agitando il braccio sano, e Laura si affacciò a guardare.
Scendeva una pioggia estiva così lieve che le goccioline si asciugavano subito a contatto della strada. Le nuvole non avevano abbastanza forza da coprire il cielo, e le pietre del selciato luccicavano ai raggi del sole.
Un uomo camminava trascinando un mulo con insulti, botte e carezze. Era stato lui a salutare Fioreste: monsù Albino, che aveva una casetta e un campo vicino al ponte.
«Cerèa, Bino!» lo salutò Laura, anche lei in torinese. «Che notizie?»
L’uomo si fermò a guardarla e le rivolse un sorriso triste, grattandosi i capelli sudati sotto il cappello di feltro.
«La Congregazione vuole proibire le adunanze di popolo e le processioni per paura delle bombe.» Il mulo scosse la testa come se l’avesse voluto contraddire, e lui diede uno strattone alla cavezza.
«Bisognerebbe che cadessero pagnotte dal cielo anziché bombe, nessuno patirebbe più la fame» commentò Laura. Ogni giorno aumentava la fila dei poveri davanti alle mense delle chiese e dei conventi.
«Il giorno che cadranno pagnotte dal cielo, alla fame non penseremo più.»
Albino mise una mano in tasca e tirò fuori mezza cipolla. Ne addentò un bel morso e si pulì le labbra con la mano.
Era sceso un improvviso silenzio. Albino fece un sospiro e disse:
«Noi andiamo, cerèa tòta.»
«Cerèa Bino.»Le campane della Consolata cominciarono a cantare; dopo un attimo si unirono quelle del Duomo, delle chiese di Santa Chiara e Sant’Agostino, poi di tutte le altre, in un concerto che sembrava una melodia.
Le cinque del pomeriggio. Presto le ombre proiettate dalle mura di Torino si sarebbero allungate sulle prime case di Borgo Dora, sui mulini e sulle fabbriche, dando ristoro dal calore di quell’estate tanto calda.Fu allora che Laura vide Filippone attraversare la strada.
Era un omino tracagnotto, un po’ lento di comprendonio, ma gentile e ingenuo. Quasi tutti i giorni andava col fratello al mercato in città,
tirando senza fatica un carretto carico d’ortaggi: ma adesso era solo e camminava senza una direzione, la testa sollevata al cielo e la bocca aperta come per bere la pioggia.Laura stava per chiamarlo, quando lui si fermò davanti alla casa del cestaio Jean-Cristophe Favre e prese a guardarla con insistenza. Non era diversa dalle altre case in quella zona del Balòn: la bottega al piano di sotto e le stanze a quello di sopra, il recinto, il cortile con il piccolo orto, l’intonaco biancastro che non si era ancora squamato al sole.
Ma la porta era chiusa e le finestre sbarrate. Lo erano già da qualche giorno: ed era da qualche giorno che Laura non vedeva Jean-Cristophe.
Molti torinesi erano scappati prima dell’inizio dell’assedio. Dopo che le bombe erano iniziate a cadere altri li avevano seguiti, trascinati dall’esempio dei nobili: la famiglia del Duca, metà della Congregazione, e perfino Sua Altezza Reale in persona, alla testa della cavalleria.Come spinto da un’ispirazione improvvisa, Filippone aprì la porta della casa del cestaio. Fece un passo avanti per affacciarsi, poi arretrò
di scatto. Mentre s’incamminava di nuovo sotto la pioggia leggera con un passo che sembrava una corsa, borbottava qualcosa che Laura era troppo distante per sentire.
Era una scena molto strana: ma era anche strano che Jean-Cristophe avesse lasciato Torino senza nemmeno salutare i suoi vicini.«Papà, avete visto monsieur Favre negli ultimi giorni?» Fioreste scosse la testa.
Laura continuava a pensare allo strano comportamento di Filippone, e ripensò alla notte in cui Fioreste era stato male: tutti i vicini avevano sfidato la paura dell’Uomo del Crocicchio per offrire il loro aiuto.
«Vado a vedere se ha bisogno di qualcosa.»Si sentì addosso gli occhi di Fioreste, li evitò per non lasciargli leggere i dubbi e la paura. La mente era l’unica parte di lui rimasta agile come un tempo.
Si tolse il grembiule e prese dal banco i guanti di seta, da due anni suoi compagni quasi inseparabili. Ogni volta che abbassava gli occhi
per guardarsi le mani deturpate, Laura aveva l’impressione di sentire sulle labbra il sapore salato delle lacrime. Non quelle versate il giorno dell’incidente, mentre la soda bruciava la carne, ma quelle che sapevano di rimpianto e vergogna.Era già sulla porta, quando Fioreste le disse: «Po-u-ta il cane.»
Anche lui aveva paura. Oppure era riuscito a sentire quella di Laura, a dispetto degli sforzi con cui lei aveva cercato di nascondergliela.Il cortile ospitava l’orto, il gabinetto, il capanno degli attrezzi e una tettoia sotto cui si riparava il cane. Non appena la vide, Calandrino
cominciò a scodinzolare, uggiolando.
«Vieni» gli disse Laura. Mentre armeggiava con la corda per slegarlo dalla staccionata, Calandrino era troppo grato e felice per accorgersi che le stava leccando il guanto di stoffa e non la pelle della mano.Per strada c’erano alcune donne che portavano grosse ceste di panni, e che guardarono Calandrino con timore. Era un cane dall’indole mite, ma era pur sempre un grosso cane, imparentato con i lupi, che tirava la corda del guinzaglio con tale forza da minacciare di strapparla. Calandrino le ignorò, curioso di scoprire quel breve tratto di strada lontano da casa.
Si fermarono davanti alla porta di Jean-Cristophe e Laura notò che era chiusa. Avrebbe giurato che Filippone l’avesse lasciata aperta, nella sua ansia di
(fuggire)
allontanarsi.
Abituata a riconoscere i profumi più fini, Laura ebbe prima la sensazione di annusare qualcosa, e subito che non ci fosse niente da annusare.
Niente di diverso dall’odore di pollame, sudore, pane sfornato che, quando il vento soffiava dalla parte giusta, nascondeva quello putrido
delle concerie.Invece qualcosa c’era, e anche Calandrino l’aveva riconosciuto non appena era giunto all’ombra della casa, perché aveva smesso di tirare e fiutava l’aria, le orecchie e la coda dritte. Laura percepiva quella vigile consapevolezza, e non sapeva se sentirsi rassicurata o spaventata.
«Monsieur Jean Cristophe?»
Nessuno le rispose. Si sentì attraversare da una vampata di calore, chiuse gli occhi aspettando che passasse.
Non sentiva alcun suono provenire da dentro, ma aveva la curiosa impressione che i rumori intorno a lei, e perfino la sua voce, suonassero meno vividi. Come se fossero stati assorbiti dall’ombra stranamente imponente della casa, che pure era piccola.Toccò la porta che si aprì come una bocca affamata. Calandrino annusò freneticamente, ma non si mosse di un passo.
Laura guardò dentro: l’unica stanza era vuota, impregnata dell’odore di muffa e avanzi di cibo ormai guasto. Sul tavolo pasteggiava una colonia di formiche. Il pagliericcio era intatto. Non c’era nulla che facesse pensare a una sciagura, ma Laura capì che qualcosa doveva essere successo.Ecco cos’aveva sentito Filippone, poi Calandrino, e adesso lo sentiva anche lei: il disagio di chi si trova al posto sbagliato, di chi ha visto qualcosa che è meglio non vedere, pur senza sapere cosa.
Aveva già conosciuto quella sensazione, e tornava a provarla ogni volta che si soffermava a pensare al modo in cui aveva ereditato la sua bottega.
Era un lascito del saponaio Bruno, il suo vecchio padrone, che le aveva scritto una lettera per dirle che andava ad espiare il suo rimorso in un monastero.
Quale rimorso, per quale crimine? La lettera non lo diceva.E Bruno non sapeva scrivere.
Un dettaglio mancante, come nella casa vuota di Favre. Un dettaglio che Laura non riusciva a trovare ma che a volte le sembrava che vagasse come un’eco lontana dentro di lei.
Un brivido la attraversò con violenza.
Fece un passo indietro e si tirò contro la porta, asciugandosi un velo di sudore.Jean-Cristophe poteva essere rimasto ferito da qualche parte in città.
Succedeva di continuo: una scheggia sollevata dallo scoppio di una bomba, un pezzo di cornicione franato nella via di sotto. Forse tra qualche giorno il cestaio sarebbe tornato a casa con una benda sulla testa e avrebbe ricominciato a intrecciare vimini per venderli al mercato.Oppure gli era successo qualcosa di più brutto. Molto più brutto.
Per la seconda volta quel giorno, il pensiero di Laura tornò all’Uomo del Crocicchio che portava via la brava gente per prendersi la loro anima.
La Congregazione aveva vietato le processioni religiose per evitare che gli assembramenti di persone finissero sotto il tiro delle bombe
francesi. Laura non poté fare a meno di chiedersi se quella decisione non avesse reso più forte il nemico di Dio.***
Palazzo Graneri
Le strade di Torino erano le stesse di tutti i giorni, rumorose e brulicanti di gente, eppure non erano le stesse.
Le pattuglie della guardia civica erano più frequenti e guardinghe. Dai vicoli e dai mercati erano scomparsi i mendicanti, accolti nell’Ospedale di Carità, che lo volessero o no. Servi e monaci, suore e vivandieri indugiavano davanti ai banchi del mercato senza comprare, scegliendo con cura merci che costavano molto più di qualche giorno prima. E poi c’erano i profughi in fuga dalle campagne: uomini e donne di ogni età, dagli sguardi stanchi, spaventati, sconfitti.Mentre costeggiava il giardino del principe di Carignano, il conte Giovanni Battista Gropello si chiese quanti di quei profughi fossero spie infiltrate dal nemico.
Due dame dall’aspetto matronale, tutte in ghingheri e pizzi, gli passarono davanti parlando fitto fitto.
«È una follia restare ancora!»
«Perfino Sua Altezza è fuggito…» Riconobbero Gropello e gli rivolsero un sorriso imbarazzato. Ricominciarono a parlare, ma a bassa voce.Dietro le alte cancellate e gli alberi del giardino del principe di Carignano emerse palazzo Graneri, tre piani di elegante pietra bianca di
Gassino e una torretta d’avvistamento. Il picchetto di guardie scattò sull’attenti al suo passaggio; Gropello ricambiò con un cenno del capo.
«Monsieur, siete atteso» balbettò un cameriere fermo ai piedi della scalinata.
«Lo so.»
«Vi… annuncio?»
Gropello ringhiò:
«Sono atteso.»
Il valletto deglutì e fece un passo di lato per lasciarlo passare.
Quando fece il suo ingresso nello studio il Conte scoprì di essere l’ultimo.
Un gruppo di uomini fissava le mappe srotolate su una scrivania, altri si dissetavano con acqua e vino. Si voltarono a guardarlo: quasi tutti indossavano le uniformi dell’alto comando.Venne ad accoglierlo il feldmaresciallo von Daun. Gropello aspettò sulla soglia il padrone di casa osservandolo mentre cercava di non urtare mobili e invitati al suo passaggio. Era un uomo alto e imponente, reso goffo da una pronunciata zoppia.
«Venite, venite monsieur Gropello.» Il suo francese era ottimo, ma l’accento alemanno era inconfondibile. «C’è un piccolo rinfresco» aggiunse, indicando un tavolo vicino alla finestra.
«Possiamo cominciare?» chiese il vicario di polizia, conte Fontanella, asciugandosi il sudore che colava sotto la parrucca. «Altri impegni mi chiamano.»Sembrava esausto e ne aveva tutte le ragioni. Le bombe cadute sulla Città Vecchia avevano costretto molti torinesi a lasciare le case e cercare riparo sotto i portici di via di Po, e questo dava lavoro sia ai ladri che agli sbirri del vicario.
Il tavolo del rinfresco era apparecchiato con pane, salame e fette di toma, calici e bottiglie di vino di Piossasco. Gropello notò che il generale si era adeguato ai gusti della corte torinese, gusti che avrebbero fatto storcere molti nasi, a Vienna come a Parigi. Era un segnale incoraggiante, da parte di chi doveva tenere uniti gli uomini del Duca nel momento più difficile.
Si servì di salame e del croccante “pane a bastoncini” che i panettieri di Torino avevano imparato a sfornare da qualche anno, poi
andò ad accomodarsi tra il maggiore della piazza Foschieri e l’ingegnere militare Bertola.Von Daun aspettò che tutti fossero seduti, aspirando lunghe boccate dalla pipa di porcellana. La fronte spaziosa e il viso rasato di fresco gli conferivano un’espressione piacevolmente rilassata, ma lo sguardo vigile nei suoi occhi faceva pensare a un’aquila in volo, pronta a planare sulla preda.
«Ho buone notizie» disse, «una lettera arrivata ieri sera. Sua Altezza Reale è giunta sana e salva a Carmagnola senza scontri con il nemico.»
«Sia lodato Dio» esultò il Vicario. Gli altri lo fecero in maniera più composta.
Gropello si limitò ad annuire, anche perché aveva la bocca piena.Il pane era croccante, fresco di forno, e il formaggio saporito: Gropello ripensò a quanto erano costate le scorte di cibo messe da parte nei mesi precedenti. Il Duca voleva che il suo popolo e i suoi soldati fossero ben nutriti, perché li amava come un padre, o per lo meno perché gli piaceva sentirselo dire, ma anche per assicurarsi che non si diffondesse la tentazione di ribellarsi o disertare.
Il governatore della Cittadella, monsù D’Allery, chiese la parola.
«Il nemico ha quasi finito di scavare la prima trincea parallela alla linea di fortificazioni» spiegò, «dalla scorsa notte ci bombardano con
una batteria di mortai che fa piovere massi nella Cittadella.»
«Quanto tempo prima che arrivino sopra le nostre gallerie?» Von Daun si rivolse al capo degli ingegneri. Bertola si accarezzò il pizzo
e rispose:
«Dipende da quanto loro saranno veloci a scavare e da quanto noi saremo bravi a impedirglielo.»
«Per questo c’è un solo modo» lo interruppe d’Allery. «Difesa aggressiva: sortite per rallentare gli scavi.»Gropello studiò quell’uomo snello dai gesti rapidi e nervosi come il suo modo di parlare. Un buon comandante: per lui parlava la carriera
di vittorie. Un soldato ligio al dovere, che a Verrua aveva guidato una resistenza ben oltre ogni attesa o speranza. Un uomo sprezzante del pericolo, capace di continuare a combattere e incitare perfino con due pallottole in corpo. Non c’era da stupirsi che i suoi uomini lo venerassero.«Come si comportano gli ussari?» chiese uno degli ufficiali imperiali al seguito di von Daun, con un marcato accento gutturale.
«Sono ansiosi di andare in battaglia» rispose D’Allery con un sorriso feroce.
Il graduato lo fronteggiò con una smorfia di disprezzo.
«Bestie selvagge sempre ansiose di sangue, io so che…»
«Ci interessa la loro obbedienza e il loro valore» lo interruppe Von Daun.Gropello si scambiò un’occhiata d’intesa con Foschieri.
I nobili austriaci avevano una bassa opinione degli ungheresi, che consideravano sudditi riottosi e alleati inaffidabili. Ma fino a quel momento i cavalieri ussari e i battaglioni di fanti che si facevano chiamare “aiduchi” avevano dato innumerevoli prove di coraggio nella difesa della città. L’estate precedente, il reggimento Bagoscy era riuscito a trattenere il nemico per oltre una settimana, resistendo all’interno di una comunissima cascina fortificata.Il Duca di Savoia era stato chiaro: contro un nemico superiore, per numero e armamenti, bisognava restare uniti. Così gli ufficiali piemontesi avevano accettato un austriaco come comandante supremo, e von Daun riconosceva davanti a tutti il valore degli ungheresi.
Nel frattempo l’ingegner Bertola aveva aperto un’altra mappa sul tavolo per illustrare le difese sotterranee: due livelli di cunicoli che si
allungavano verso la campagna, dalla Cittadella e dai principali bastioni della città.«Abbiamo scavato le gallerie di mina a sette metri» spiegò Bertola, indicando le linee che dipartivano dalla Cittadella. «Profonde abbastanza da arrivare sotto le trincee francesi facendo saltare in aria i loro cannoni. Le gallerie di contromina sono sette
metri più in basso, appena sopra le falde di acqua. Da lì saremo capaci di bloccare gli scavi dei minatori nemici.»
«Come arriva l’aria lì sotto?» Gli occhi di Von Daun guizzavano, freddi e intelligenti.
«Stavo per dirvelo: sarà il nostro punto debole» ammise l’ingegnere. «I pozzi d’aerazione sono stati chiusi per ragioni di sicurezza, quindi dobbiamo lasciare aperti gli accessi alle gallerie direttamente nel fossato.»
«Se il nemico riesce a scendere nel fossato…» Von Daun scosse il capo e i boccoli della parrucca danzarono attorno al suo collo. «Entrerà nelle gallerie… e da lì nella Cittadella.»
«Parlateci chiaro» intervenne Gropello. «Quant’è concreto il rischio?»
«Il fossato è profondo sei metri, liscio e ripido come il collo di un fiasco di vino» assicurò D’Allery. «Dovrebbero riuscire a calarsi con le
corde, sotto il fuoco dei nostri moschetti. E se anche ci riuscissero, i granatieri sorvegliano gli ingressi alle gallerie.»
Il suo ottimismo era contagioso.
«Il capitano Bozzolino» continuò «ha istruito la compagnia di minatori: se per malaugurio i francesi dovessero conquistare una delle gallerie superiori, verrà fatta saltare la scala di collegamento.»
«Quando dovremo preoccuparci delle gallerie?» chiese Von Daun al Bertola.
«Non prima di metà luglio» rispose l’ingegnere, e un mese era abbastanza tempo da spostare il problema in secondo piano.Il consiglio di guerra passò a discutere l’organizzazione dei rifornimenti e degli ospedali, il pattugliamento fuori città, l’addestramento
della milizia urbana.
Il vicario di polizia espose la sua preoccupazione per l’aumento dei furti, anche se la minaccia della forca era stata un buon deterrente: un solo saccheggiatore era stato colto con le mani nel sacco, e subito impiccato.
Delle scorte fece il punto lo stesso Gropello:
«Abbiamo bestiame, farina, olio e vino per cinque mesi. C’è tutta la polvere da sparo che si potesse comprare, a qualunque prezzo… Ne
stiamo fabbricando altra, ma non sono sicuro che sia abbastanza. Credo sia meglio che Sua Altezza Reale sia messo al corrente di quanta ce ne resta dopo ogni giorno di guerra.»
Von Daun si limitò a un cenno d’assenso: la questione della polvere era già stata discussa prima della partenza del Duca.Prese la parola Foschieri per dire che i suoi uomini stavano sorvegliando le famiglie francesi a Torino, in particolare gli elementi sospettati
di collaborare col nemico. Alcuni erano già ospiti delle carceri sabaude, altri sarebbero andati a raggiungerli nei prossimi giorni.Il generale Isnardi di Caraglio prese la parola. Era un uomo dalle spalle larghe, con l’aspetto d’un guerriero d’altri tempi. Come il conte
d’Allery, anche lui aveva la fama di eroe: si era distinto nel difendere fino all’ultimo uomo la cittadella di Nizza. Per questo il Duca lo aveva nominato governatore di Torino.
«Sono giorni difficili» esordì, girando attorno al tavolo. «Sugli spalti servono uomini forti e calmi, ma bisogna che anche il popolo sia forte e calmo, in modo che noi possiamo dedicare tutte le risorse alla difesa.»
«I torinesi hanno fede nella vittoria» assicurò Foschieri. Nessuno poteva dirlo meglio di lui, che si aggirava in incognito tra la gente per saggiarne gli umori. E, si diceva, per far tacere le lamentele e i dissensi.
«Hanno fede nella vittoria perché hanno fede in Dio.» Gropello si riferiva al prodigio dell’eclisse del 12 maggio. A distanza di due mesi,
quel miracolo faceva ancora parlare: nelle osterie, tra i banchi dei mercati, ai lavatoi e perfino nelle chiese, durante le celebrazioni.Il Duca non avrebbe potuto sperare in un prodigio più favorevole a benedire la battaglia decisiva.
Gropello aveva abbastanza esperienza da sapere che molti eventi guidati dal caso potevano venire ingigantiti dalla fede e dalla superstizione. Lui stesso, meno di due anni prima, aveva fatto giustiziare una pazza con la fama di strega, colpevole solo di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato.
«Faremo bene a non confidare troppo nella fedeltà del popolo» ammonì. «Potrebbe cambiare come cambia il vento.»
Il marchese di Caraglio divenne scuro in volto.
«Da quando il Duca ha lasciato la città, molti stanno cercando di fuggire.»
«Nessuno qui fugge.» Lo sguardo di von Daun era di ghiaccio. «Nessuno. Se no c’è la forca.»
«Sua Altezza Reale aveva solo due scelte» ricordò d’Allery, con impeto. «Star chiuso dentro le mura di Torino, o disturbare le azioni del nemico con la cavalleria.»«Il difetto dei soldati… e dei generali» aggiunse Gropello quando i suoi occhi incrociarono quelli del governatore «è sempre una visione
militare delle cose.»
«Se sapete qualcosa che noi ignoriamo, parlate» lo invitò Bertola.
Gropello si alzò in piedi, ottenendo subito il silenzio.
«L’altra notte un ufficiale francese ha fatto una passeggiata davanti alle postazioni avanzate della Cittadella. Sotto il tiro dei nostri cecchini. Quante volte sostengono di averlo colpito, monsù D’Allery?»
Il comandante della Cittadella lo fissò stupefatto: «Voi come lo sapete?»
«Quante volte, monsieur?»
«Tre. Ma era poco dopo il tramonto, la luce era poca…»
«Tre colpi. Uno al petto, uno alla spalla e uno alla testa» Gropello spostò lo sguardo su Von Daun, poi su Caraglio. «E l’ufficiale, dicono
i cecchini, non è morto. Non è caduto. Come se non si fosse accorto di essere stato colpito.»
«È una fandonia!» esclamò Bertola. Gropello lo guardò con un sorriso amaro:
«Chiaramente è una fandonia. Ma cosa dicono i soldati che erano di guardia?»
Incalzato dagli sguardi dei presenti, il governatore rispose con un filo di voce:
«Che l’ufficiale era una specie di diavolo.»Gropello annuì, senza l’ombra di un sorriso.
«E voi, monsù Foschieri, volete raccontarci le dicerie di Borgo Dora e nell’isola di San Francesco su certe persone che la sera non fanno
ritorno a casa?»
«Dicono che è il Diavolo a portarli via» rispose il maggiore della piazza, stringendo le labbra in una smorfia di disappunto.
«Non sono queste le cose di cui dobbiamo preoccuparci» obiettò Von Daun.
«E invece sì.» Gropello tornò a sedersi, spostando lo sguardo su ciascun membro dell’alto comando. «Un diavolo che si aggira tra le trincee francesi e studia le nostre difese. Un diavolo che rapisce i torinesi dei quartieri poveri. Fantasmi che risorgono e si manifestano agli occhi dei loro cari. Questi sono segni, segni che il popolo potrebbe leggere a nostro sfavore. Non sono partiti solo il Duca e la sua famiglia. Anche la Sindone non è più in città, e prima o poi qualcuno potrebbe ricordare che Torino non gode più della protezione della più santa delle reliquie. Finché il popolo crederà che Dio è dalla nostra parte, non dovremo temere disordini. Ma se dovesse capitare il contrario…»Nessuno ebbe la forza, o il coraggio, di finire la frase.
***
Parco del Viboccone
I bambini camminavano lungo il viale del parco del Duca, sotto la
volta di una cattedrale fatta di rami e foglie. Erano vestiti tutti uguali,
calzoni neri e camicia bianca, e formavano una fila ordinata, come piccoli soldati.Educati, gentili, silenziosi.
Così gli orfanelli dell’Ospedale di Carità mostravano gratitudine verso il Duca e verso le istituzioni che si erano prese cura di loro.
Quel giorno avevano scoperto fontane con giochi d’acqua, aiuole di
fiori, radure nascoste, piccole colline e isolette. Da lontano avevano anche ammirato le corna di un cervo. Erano gli incanti della tenuta di caccia del Duca, di cui la corte poteva godere a piacimento, e che ogni tanto, con gran sfoggio di cristiana carità, venivano offerti ai sudditi più sfortunati.C’era una fenditura nel fianco della collina, una rientranza impossibile da vedere a meno di prestarvi molta attenzione, eppure larga abbastanza da permettere di entrare uno per volta. Conduceva in una grotta col pavimento di pietra, e la cascata era una tremula parete che lasciava passare la luce del sole.
Sto sognando.
La consapevolezza attraversò Gustìn mentre il se stesso bambino entrava in una finta grotta e vi scopriva panche con cuscini e un tavolo imbandito di biscotti e panini con burro e zucchero.
Era un sogno fatto di ricordi sbagliati.
Il parco e la grotta artificiale erano quelli del Viboccone, ma Gustìn non poteva averlo visto da bambino perché era stato chiuso molto tempo prima che lui nascesse.
La visita degli orfanelli nel parco del Duca era accaduta davvero, sì, ma alla Venaria, mentre la vecchia tenuta di caccia del Viboccone aveva accolto alcuni incontri segreti di Gustìn quando già lavorava per Gropello, per questo riconosceva i luoghi.
Il suo sogno stava mescolando ricordi di età diverse alle fantasie del bambino che era stato, quando le caverne dall’aspetto misterioso nascondevano tesori e incredibili avventure.Rivivendo quel ricordo vide padre Olindo con il suo sorriso.
(Un sorriso falso come quello di Giuda)
Il bambino che giocava nella finta grotta non sapeva che qualche anno dopo avrebbe odiato il prete con tutto il cuore. Che avrebbe cercato di ammazzarlo, per quello che aveva fatto a… Milo.(Lui… è qui?
Sì, c’era. C’era anche lui quel giorno.)Guidato dalla consapevolezza del se stesso adulto, il Gustìn bambino si voltò a guardare l’amico inseparabile della sua infanzia.
Milo era troppo magro, perfino tra gli orfanelli dell’Ospizio di Carità, e troppo pallido, con i segni viola sotto gli occhi di chi dorme troppo
poco. Si stancava e si ammalava facilmente, eppure quel giorno aveva fatto di tutto per essere il primo della fila. Forse per essere sicuro di vedere tutto quello che poteva, il più in fretta possibile: come se avesse saputo che non gli rimaneva abbastanza tempo.Il ricordo della morte di Milo penetrò con violenza nella mente di Gustìn
(morte imminente… oppure già avvenuta?)
e gli fece così male che minacciò di svegliarlo.
«T o r n a a s o g n a r e, G u s t ì n!» disse Milo con una voce che sembrava troppo lontana. Lo prese per mano, trattenendolo accanto a
lui nel sogno, come per chiedergli di rimanere piccoli e senza pensieri ancora per un poco, dimenticando entrambi di essere l’uno diventato adulto, l’altro cibo per i vermi.Era stato Gustìn ad accorciare il suo vero nome, Camillo.
Torna a sognare!
Il tenente che conduceva la visita al parco fece segno ai bambini di seguirlo per un’ultima sorpresa. Dell’ufficiale Gustìn non ricordava il nome né il viso, ma avrebbe potuto descrivere nei particolari il numero di galloni d’argento sulla divisa blu del reggimento Guardie, la forma delle fibbie degli stivali, la foggia del cappello.
Oltre alla cascata c’era un sentiero tra due file di gabbie dov’erano rinchiusi grossi animali d’aspetto minaccioso, bestie feroci che la Famiglia Reale aveva portato a Torino da ogni parte del mondo.
Il bambino Gustìn sentì soltanto puzza di merda e piscio, ma la coscienza che viveva in lui e che sapeva tutto avvertì qualcos’altro. Qualcosa di oscuro.
Un brivido lo percorse quando le dita della mano che stringeva nella sua divennero aguzze come ramoscelli e fredde come ghiaccioli.
Comprese, con la certezza che appartiene solo ai sogni, che il bambino che lo teneva per mano era morto eppure in qualche modo cosciente. Quella stessa gelida certezza gli suggerì la parola “risvegliato”.Non guardarlo in viso! si sentì dire, ma la voce non usciva dalla bocca.
Parlò invece Milo, di nuovo con quella voce strana«F e r m a l i G u s t ì n!»
Chi devo fermare?
(Non guardare Milo!)
Cosa devo impedirgli?
(Non guardarlo, per carità!)«F e r m a l i o s u c c e d e r à q u a l c o s a d i t e r r i b i l e.»
Voglio svegliarmi, pensò nitidamente. Voglio tornare a casa.
«T u s e i g i à a c a s a» sibilò Milo.
Attratto da una volontà estranea e implacabile, lo sguardo di Gustìn si posò sulla gabbia più vicina. Era vuota, ma conteneva dei mobili.
Mobili di una camera da letto. La sua camera.Gustìn aprì gli occhi e scoprì di essere sdraiato nel suo letto: i tenui bagliori color latte della luna s’insinuavano dalle fenditure della finestra rivelando i contorni della stanza, l’armadio, la cassapanca, il tavolino con lo specchio e la bacinella.
Non provò nemmeno a cercare di riaddormentarsi. Glielo impedivano il cuore che batteva fortissimo e la sensazione di puzza che sembrava uscita dal sogno per aggrapparsi a ogni pelo nelle sue narici. Puzza di selvatico, di serraglio, di belve feroci.
Udì il soffiare di un gatto.
Castore e Polluce avevano abbandonato la loro posizione preferita, in fondo al letto. Castore aveva il pelo fulvo e i modi guardinghi, e occhi astuti da cacciatore; Polluce era smilzo e nero come la notte, lo sguardo vivace.Gustìn vedeva le loro sagome sotto il tavolo della toeletta, le code basse e gonfie, lo sguardo fisso in direzione della cassapanca.
Li chiamò e loro non risposero, immobili come solo un gatto sa essere quando studia una preda. O un altro predatore.
Solo allora Gustìn si accorse che nella stanza faceva freddo. Un freddo concreto, reale, come quando si è preda della febbre.Il caldo di quell’estate del 1706 toglieva il fiato, e lui era scosso dai brividi.
***
Palazzo Levaldigi
La vedova del conte Truchi di Levaldigi, Maddalena Quadro, chiuse la porta.
Girò la chiave nella serratura e nascose la porta dietro il tendaggio di velluto nero. Tutte le pareti della stanza erano coperte di nero, tranne una nicchia, a cui si accedeva varcando un sottile velo di stoffa bianca.La vedova controllò che sul mobiletto accanto alla parete tutti gli oggetti fossero disposti nel modo giusto: inchiostri, pennelli, un flauto e
tre campanelle d’argento. Infine raggiunse al tavolo il consigliere Bonaventura Dentis, che la aiutò ad accomodarsi prima di farlo a sua volta. Solo allora cominciò a parlare:«Mi preme rammentarvi il vostro giuramento: nulla dovrà essere divulgato, per nessun motivo al mondo.»
L’uomo alla sua sinistra, il botanico Filippo Monier, teneva le mani sulle spalle della moglie, già seduta al tavolo. Il viso accigliato di lei, la
sua postura rigida, piegata in avanti, davano la sensazione che cercasse di sfuggire a quella presa, piuttosto che esserne protetta. Entrambi annuirono.«Le nostre sedute hanno un unico motivo» continuò la dama. «Avere la possibilità di parlare con i nostri cari. Da quando ci siederemo a quel tavolo, le nostre volontà e i nostri pensieri dovranno essere interamente votati a questo scopo.»
«Non occorre ricordarcelo» protestò Monier.
«Sì, invece.»A parlare era stata l’unica persona nella stanza che non indossava un abito di squisita fattura, una parrucca ben acconciata o gioielli di valore. Una donna di età avanzata, con addosso vestiti dai colori troppo vivaci perfino per i gusti delle dame più stravaganti, un foulard a nasconderle i capelli. L’unico gioiello era un ampio orecchino dorato. La donna, già seduta al tavolo in corrispondenza dell’unica tenda bianca della sala, era una zingara.
Quella presenza avrebbe potuto screditare la reputazione della padrona di casa e perfino dei suoi invitati: non molti anni prima, la Madama Reale aveva proclamato editti severi contro i gitani. Eppure, quando la zingara disse “sì, invece”, nessuno osò metterla a tacere. Nessuno osò contestare quelle due parole.«Siete persone istruite, senza pregiudizi» dichiarò la Contessa, dopo un lungo silenzio. «Avete già incontrato apparizioni come quelle che
cercheremo di evocare stasera. E ben sapete come io non sia nuova a tali esperimenti. Ma vi posso giurare, su ciò che mi è più caro, che in questa casa non erano mai avvenuti prodigi tanto straordinari come quelli a cui ho assistito nelle ultime notti.»Dall’esterno proveniva il rombo delle cannonate: l’attacco alla Cittadella era ricominciato. Eppure, in quel luogo sepolto sotto spesse fondamenta di pietra, il mondo reale sembrava lontanissimo.
«Perché gli spiriti sono agitati?» domandò Monier. La vedova scosse la testa: non sapeva perché da qualche giorno i sussurri fossero diventati grida, o perché ciò che prima era stato invisibile avesse scelto di manifestarsi in modo tanto chiaro.«Forse domanda non giusta.» La zingara aveva una voce che pareva quella di una ragazzina. «Forse domanda giusta non è “perché”,
ma “per chi” spiriti sono agitati?»
«Volete dire che qualcuno sta agitando gli spiriti?» Il consigliere Dentis sembrava parlare in falsetto. Si diceva che fosse stato castrato da bambino affinché potesse dedicarsi al canto.
La zingara lo fissò con i suoi occhi di un castano rossiccio: occhi intelligenti, che come la voce sembravano di una persona molto più giovane.
«Qualcuno scava in parete tra nostro mondo e quello di morti.»
Una bomba scoppiò vicina, seguita da grida di paura e di allarme.«Possono farci del male?» chiese la moglie di Monier.
«Spiriti non ha potere su vivi, se vivi non concede. Se tu cerca paura, tu ha paura. Se tu cerca insegnamenti, tu riceve.»
«Ma se vogliamo incontrare una persona amata non è detto che verrà.» C’era una nota amara nella voce della vedova. «Non si può sapere se lo spirito si manifesterà e rimarrà in silenzio, o se non risponderà alla chiamata.»
«Ma se è vero che le apparizioni in questi giorni rispondono in modo più nitido che in passato…» la moglie del botanico fece un lungo sospiro «non c’è momento migliore per provare a parlare con i nostri defunti.»Lo pensavano tutti. Per quello erano lì.
In silenzio presero posto, mentre Dentis spegneva tutte le lampade della sala, tranne quella sul tavolo, che aveva i vetri verniciati di rosso: il baluginare sanguigno permetteva di distinguere i visi e le mani dei presenti, avvolgendo invece la sala in una tenebra che ne faceva smarrire le dimensioni. Il tendaggio dietro la zingara, esposto a quella luce, sembrava una cortina di nebbia scarlatta affacciata sul nulla.
«Formiamo la catena» comandò Dentis, e tutti allungarono le mani sul tavolo, incrociandole con quelle dei vicini. «Il nostro spirito guida è
un soldato austriaco, crediamo sia caduto pochi giorni fa durante l’assedio. Si chiama Stephan. Tre colpi quando risponde sì, due per il no. All’inizio lasciate che sia madame la contessa a porgere le domande, poi parlate uno per volta.»Prese un campanello e lo fece suonare tre volte: il trillo si prolungò nell’aria in piccoli echi fino a svanire nel nulla.
Il silenzio durò un istante, poi la zingara cominciò a borbottare qualcosa nella sua lingua. A poco a poco, i lineamenti diventarono rigidi
come una maschera, la testa appoggiata sulla spalla e la bocca socchiusa.
Borbottava a voce sommessa, con interruzioni sempre più lunghe della sua musicale parlantina.Sussultò una volta. Una seconda.
La tenda alle sue spalle cominciò a gonfiarsi.Il drappeggio faceva intuire la forma di un viso, di una parrucca militare e perfino di baffi. Divenne la sagoma di un uomo. Era come se una persona si fosse avvolta nei veli e vi fosse passata attraverso.
«Mi ha toccato la spalla!» esclamò la moglie di Monier.
«Descriveteci cosa succede» la invitò il consigliere.
«È… una mano. Grande, pesante. Una grossa mano!»
«Siamo in presenza del soldato Stephan?» chiese Dentis ad alta voce.
Tre pacche si susseguirono una dietro l’altra.
«Mi ha preso per un braccio… come per staccarmi dalla catena!» La voce della donna tremava eccitata.
«Lasciatelo fare!» esclamò la vedova.
Il braccio destro della donna si sollevò, la mano ruotò all’indietro, muovendosi piano a descrivere un piccolo cerchio.
«Sto toccando un viso! Sento i baffi che mi pungono le dita.»
«È lui» disse il consigliere «vuole farsi riconoscere.»A conferma di quelle parole, si levò nell’aria un odore estraneo: sudore e polvere da sparo. La vedova suonò il campanello.
«Soldato Stephan, vi chiedo se altre entità sono presenti.»
Si udirono tre colpi sul legno del tavolo rimasto al buio. Sì.
«Vogliono manifestarsi?»
Due colpi. No.
I presenti si scambiarono sguardi confusi, escludendo la zingara, l’unica immersa in uno stato simile al sonno.
«La nostra chiamata vi ha offesi?» continuò la contessa.
No.
«Qualcuno tra noi vi procura fastidio?»
No.
«Qualcosa vi impedisce di parlare?»
Tre colpi. Sì.
La voce del botanico tremò nel silenzio.
«Qualcuno vi impedisce di parlare?»
Sì.
Una corrente d’aria gelida si insinuò nella stanza, facendo muovere le tende.
«Siamo in presenza del soldato Stephan?» riprovò la vedova.
Sì.
«E ci sono altri spiriti in questa stanza?»
Sì.
«Qualcuno che… abbiamo amato?»
Sì.
«Posso parlare con lui?»No.
La zingara mosse la testa come per allontanare un insetto fastidioso.
A tutti fu chiaro che stava facendo cenno di no.
Vi fu un’altra ondata di gelo, più forte della precedente: la accompagnò una nauseante zaffata di odore dolciastro. La contessa era vicina alle lacrime:
«Vi imploro!»
Il consigliere Dentis aprì la bocca e per qualche istante sembrò quasi in lotta con se stesso, incapace di proferir parola. Poi gridò:
«Di chi avete paura? Chi vi minaccia?»Rispose un rumore di vetro che batte su legno, poi un altro, più sottile, come quello di una mano che gratta sulla porta con le unghie.
Un ultimo refolo di vento freddo fece tremare le tende. Poi la zingara aprì gli occhi, lentamente. Si guardò intorno e disse:
«Andati via.» Era stremata.Il consigliere si era alzato per accendere i lumi, la sua voce parve arrivare da lontanissimo. «Venite a vedere.»
Sul tavolo contro la parete era stata rovesciata una boccetta di inchiostro, qualcuno aveva scritto sulla tovaglia di lino:
le Traditeur
Una parola francese che ormai si udiva soltanto in chiesa, vecchia di secoli. La lingua comune preferiva “traître” per indicare il traditore.
Gocce di inchiostro colavano dalle estremità contorte delle lettere.Sembravano lacrime color cenere.
Torino, 18 giugno 1706