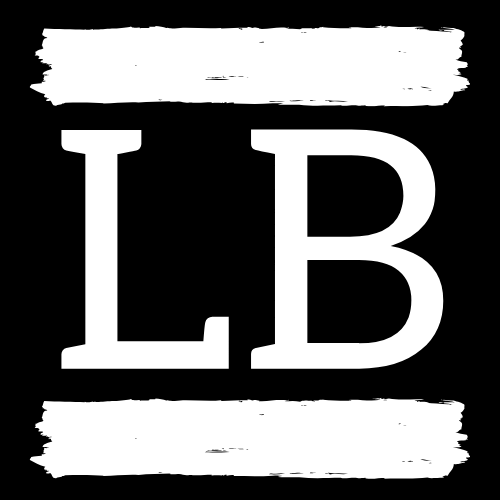“Chiunque abbia troppo accostato alle labbra il calice della voluttà; chiunque abbia occupato nel lavoro gran parte del tempo destinato al sonno; chiunque, essendo uomo intelligente, si sente momentaneamente svanito; chiunque non possa sopportare l’aria umida, il tempo lungo, l’atmosfera pesante; chiunque sia tormentato da un’idea fissa che gli toglie la libertà di pensare: tutti costoro si prendano un buon mezzo litro di cioccolata ambrata…”
(Anthelme Brillat-Savarin, politico e gastronomo, 1755 – 1826)
Il cacao venne importato dagli Spagnoli in Europa all’inizio del 1500. All’inizio della sua diffusione si trattava di una bevanda, il processo di solidificazione con cui consumiamo oggi il cioccolato arrivò durante il XIX secolo. Mentre gli indigeni delle colonie spagnole mescolavano il frutto del cacao (tostato e polverizzato) alla farina di mais e al peperoncino, gli spagnoli scoprirono la mescita con lo zucchero, la vaniglia e gli aromi orientali, la scorza di frutti canditi: il successo della “cioccolata” divenne così indiscusso.
I torinesi furono tra i primi a poterne gustare il sapore, grazie agli ottimi rapporti tra il Duca Emanuele Filiberto di Savoia e la corte di Spagna. I francesi, per esempio, che con gli spagnoli non andavano sempre così d’accordo, dovettero attendere un altro secolo, quando la golosissima sposa di Luigi XIV ne ispirò l’utilizzo nella preparazione di dolci e bevande.
Nel seicento e nel settecento il cacao divenne protagonista indiscusso sulle tavole di tutta Europa, dando risalto alla figura del pasticciere che diventa una cosa a sé rispetto al cuoco. Uno scritto dell’epoca racconta:
«Il cioccolatte è una mistura o confezione fatta di vari ingredienti, tra i quali tengono il maggior luogo il cacao abbronzato e il zucchero. Così fatta confezione messa nell’acqua bollente con l’aggiunta di nuovo zucchero serve di bevanda a’ popoli americani della Nuova Spagna. E di là trasportatene l’uso in Europa, è diventato comunissimo, e particolarmente nelle corti de’ Principi e nelle case de’ Nobili, credendosi che possa fortificare lo stomaco e che abbia mille altre virtù profittevoli alla sanità. La corte di Spagna fu la prima in Europa a ricever tal uso. È veramente in Ispania vi si manipola il cioccolatte di tutta perfezione; ma alla perfezione spagnola è stato a’ nostri tempi nella corte di Toscana aggiunto un non so che di più squisita gentilezza, per le novità degli ingredienti europei, essendosi trovato il modo di introdurvi le scorze fresche de’ cedrati e de’ limoncelli e l’odore gentilissimo del gelsomino, che mescolato colla cannella, colle vainiglie, coll’ambra e col muschio, fa un sentire stupendo a coloro che del cioccolatte si dilettano».
La diffusione e il consumo divennero così diffusi, specie tra i nobili, da mettere in allarme i medici, che cominciarono a segnalarne le possibili controindicazioni: palpitazioni e mali anche cronici! Perfino la Chiesa volle dire la sua, aprendo una disputa di diritto canonico: la cioccolata infrange o meno il digiuno? La tesi dei Gesuiti prevalse sulle contrarietà del clero spagnolo, dando il consenso al consumo della dolce bevanda, a patto di non accompagnarvi quello di alimenti solidi.
La cioccolata era uno status symbol molto apprezzato dalla nobiltà. I quadri dell’epoca ci offrono ritratti precisi di quello che doveva essere un vero e proprio rituale: la colazione. La dama a letto con un cagnolino in grembo, il marito accanto a lei, un abate che legge un testo a voce alta per intrattenerli, un servitore che porta il vassoio con le tazze e i biscotti. Un rito che simboleggia il lusso e l’oziosità dei nobili, e forse non è un caso che agli inizi del secolo i borghesi preferissero simbolicamente il caffé alla cioccolata.
Come nella Venezia di Goldoni, anche a Torino c’erano locali in cui veniva venduta e consumata la cioccolata: la prima, sembra, a cogliere quest’opportunità imprenditoriale fu la vedova Arignano, che aveva un’osteria nelle vicinanze della Piazza della Frutta e della porta settentrionale. Ne fa cenno la storia d’Italia di Carlo Botta.
In queste botteghe si consumava cioccolata, ma prima ancora caffé e prima ancora del caffé l’acquavite: venivano infatti chiamati “acquavitai”. Vittorio Bersezio riferisce la rapida diffusione di questi esercizio commerciali: “nel 1839 ci sono ben 98 botteghe vere e proprie da caffè; coi liquoristi e birrai 157. Ora (nel 1884) le botteghe da caffè ascendono da se sole al numero di 180, senza contare i vermuttai, liquoristi, birrai’ e cioccolattieri”.
Il Secolo dei Lumi è alle spalle e la Rivoluzione Francese ha cambiato molte cose. La cioccolata non è più a beneficio esclusivo dei nobili, e i locali dove viene venduta non sono esattamente un modello di pulizia ad eleganza. Sempre il Bersezio ce ne da testimonianza:
“Ma chi crederebbe ora che nel primo quarto di questo secolo i Caffè torinesi, oggidl in gran parte suntuosi e quasi tutti puliti e rispondenti ai bisogni della vita moderna, consiste vano ancora in una o due sale, dal soffitto basso ed affumicat o, illuminate alla meglio dai funerei quinquets (un tipo di lampade a olio, nda) di graveolente memoria, arredate con tavolini di noce sui quali il caffè ed il cìoccolatte lasciavano una patina equivoca, e certi sgabelli di legno alti e senza spalliera che invitavano più a partire che a sedere? E non parlo dell’ambiente nauseabondo, delle mosche, del servizio! Basti ricordare che sino al 1839 era universale il lagnarsi dei Torinesi di questi sgraditissimi sconci: l’acqua da bere era recata in un bicchiere già bell’e mesciuta; quindi ad ogni scossa l’acqua traboccava nel vassoio e poi sull’abito dell’avventore, senza contare che questi, per far peggio,
buttava a terra senza riguardo tutta quella che non voleva temperare con caffè, liquori o zucchero; poi i bicchieri da caffè, latte e cioccolatte non avevano manico, e finalmente le monete del resto venivano consegnate fracide o poco men che fracide, poiché fin dalla terribile peste del 1630 durava in ogni negozio l’uso di buttare i denari in una conca d’acqua. C’era da restituire all’avventore degli spiccioli? Si tuffava la mano nella conca, se ne pigliava una manata, e si davano da mano a-mano all’avventore, dopo di aver fatto mostra di asciugarli con un cencio!”
Verso metà del secolo si diffondono le tazze con il manico, grazie, pare, all’idea di un esercente di via Doragrossa di nome Calosso. Nel 184, finalmente, l’illuminazione a gas. L’arredamento cambia come cambiano le abitudini. Nei caffé arrivano giornali italiani e stranieri, politici, scientifici, letterari e le ben diciassette tra riviste e gazzette stampate in città. Le botteghe più apprezzate pare fossero quelle del liquorista Marendazzo e del cioccolatiere Andrea Barrera, il Caffé Fiorio e il Caffé San Carlo (tuttora esistenti).
La cioccolata non viene più consumata pura ma mescolata a caffé, cioccolato, latte e sciroppo di zucchero, una bevanda nota come “bavareisa” e consumata in grandi bicchieri di vetro. Qualche anno dopo la bavareisa diventa “bicerìn“, servito in bicchieri più piccoli (da cui il nome) e dotati di manico.
Ai tavoli di queste botteghe trovano posto uomini di ogni condizione: nobili, artigiani, contadini, senatori, ministri e perfino il principe di Savoia. Perfino le signore non sdegnavano di frequentare i caffé con al sicurezza di essere rispettate.
La contessa d’Agoult, scrittrice e implacabile osservatrice, fece un grande elogio ai torinesi vedendo come tutti frequentassero i caffé nel reciproco rispetto: “a Torino amano la libertà nell’ordine“. Un tratto sabaudo di cui non dovremmo dimenticarci e andare orgogliosi.